UN PAQO IN UN MONDO TURBOLENTO
di Joan Parisi Wilcox; traduzione Gianmichele Ferrero – Dall`Archivio 26/09/2023
Recentemente, gli studenti e i colleghi paqo di diverse classi in cui insegno o co-insegno hanno espresso il loro sgomento per lo stato del mondo, in particolare per lo stato dell’universo dell’informazione creato da podcaster, esperti di mezzi di informazione e politici negli Stati Uniti. Chiedono: “Come siamo arrivati a questo livello di lamentela, esagerazione, menzogna, vergogna, ostracismo, tribalismo, rabbia e persino violenza? E come possono così tante persone essere influenzate, persuase, persino ingannate dalle stravaganti teorie del complotto e dalla disinformazione facilmente confutabile che inonda il panorama online e le vie televisive? Che cosa è successo alla logica e alla ragione, al dibattito e al compromesso? Quando abbiamo perso il rispetto per gli standard morali, la tolleranza e la semplice vecchia cortesia?
Buone domande. Non ci sono risposte facili, ma queste conversazioni mi hanno spinto a pensare alle buone maniere vecchio stile. E questo mi ha portato a pensare al valore umano chiamato “virtù”, che non solo è fuori moda, ma per gli standard odierni sembra decisamente vittoriano.
Don Juan Nuñez del Prado e suo figlio, don Ivan, hanno detto che per sviluppare meglio il munay, faremmo bene a sviluppare prima la virtù (tra alcuni altri valori). La virtù, per definirla nel modo più diretto e semplice possibile, è un comportamento alimentato da elevati standard morali. La moralità, ovviamente, è un concetto difficile da definire, poiché di solito nasce da una visione del mondo o addirittura da un dogma organizzato. Esistono vari “universi morali”. In termini di virtù, c’è il senso religioso della virtù, il senso umanistico della virtù, il senso ateo della virtù, il senso utilitaristico della virtù e così via, compresi gli standard che adottiamo non da un sistema di autorità stabilito ma dal nostro sistema di valori individualistico. Quindi, quando parliamo di virtù come di elevati standard morali, dobbiamo chiederci a quale standard stiamo cercando di conformarci?
Per rispondere a questa domanda, mi rivolgo al punto di vista di un gruppo di professori dell’Università di Santa Clara, coautori dell’articolo “Etica e virtù”. Scrivono: “Per molti di noi, la questione fondamentale dell`etica è: `Cosa dovrei fare?` o `Come dovrei agire?` Si suppone che l`etica ci fornisca `principi morali` o regole universali che ci dicano cosa dobbiamo fare. Fare. Molte persone, ad esempio, sostengono con passione il principio morale dell`utilitarismo: “Ognuno è obbligato a fare ciò che porterà il massimo bene per il maggior numero di persone”. Altri sono altrettanto devoti al principio fondamentale di Immanuel Kant: “Ognuno è obbligati ad agire solo in modo da rispettare la dignità umana e i diritti morali di tutte le persone.`”
Questi studiosi poi si chiedono: “Ma sono i principi morali tutto ciò in cui consiste l’etica? I critici hanno giustamente affermato che questa enfasi sui principi morali sa di un culto sconsiderato e servile delle regole, come se la vita morale fosse una questione di controllare scrupolosamente ogni nostra azione rispetto a una tabella di cose da fare e da non fare. Fortunatamente, questa ossessione per i principi e le regole è stata recentemente contestata da diversi studiosi di etica, i quali sostengono che l’enfasi sui principi ignora una componente fondamentale dell’etica: la virtù”.
Elencano alcune “virtù” – onestà, coraggio, compassione, generosità, fedeltà, integrità, correttezza, autocontrollo e prudenza – e spiegano che la virtù non è qualcosa che scegliamo sulla base di un`idea o di un ideale, ma è qualcosa che sviluppiamo attraverso la nostra esperienza. (Sto mettendo insieme vari punti che fanno nel paragrafo seguente.) “Le virtù si sviluppano attraverso l’apprendimento e attraverso la pratica. Le virtù sono abitudini. Cioè, una volta acquisiti, diventano caratteristici di una persona. Al centro dell’approccio virtuoso all’etica c’è l’idea di “comunità”. I tratti caratteriali di una persona non si sviluppano isolatamente, ma all’interno e attraverso le comunità a cui appartiene, tra cui la famiglia, la chiesa, la scuola e altre comunità private. e associazioni pubbliche. La vita morale, quindi, non è semplicemente una questione di seguire regole morali e di imparare ad applicarle a situazioni specifiche. La vita morale è anche questione di cercare di determinare il tipo di persone che dovremmo essere e di occuparci dello sviluppo del carattere all’interno delle nostre comunità e di noi stessi”.
Questa spiegazione somiglia molto a ciò che la tradizione mistica andina chiama ayni. Ayni è spesso tradotto come reciprocità, ma dobbiamo immergerci un po’ più a fondo per discernere il suo significato più ampio. Ayni è intenzione unita ad azione, a cui seguono sia la consapevolezza che ci sarà un risultato sia una nuova azione/risposta commisurata in relazione a quel risultato. Per le popolazioni indigene andine e quechua, ayni è un valore che serve, tra gli altri scopi, a rafforzare la coesione sociale. Quando cerchi le varie definizioni oltre la reciprocità, ayni si riferisce a fare un favore e restituirlo, o fare qualcosa per qualcuno senza aspettarsi nulla in cambio (sebbene la dinamica energetica sia che l`universo vivente ti restituirà sami). Quindi ayni coinvolge sempre sé e gli altri, in modo tale che le nostre scelte siano basate sulla considerazione di come entrambe le parti possono trarne vantaggio. Ayni come applicazione della virtù, quindi, è un valore vissuto. Un valore è una scelta su chi vogliamo essere. La virtù, come ayni, è un`applicazione della volontà per applicare quel valore, o gruppo di valori, per rivelare come effettivamente presentiamo nel mondo.
Come CS Lewis ha spiegato la relazione tra un valore e una virtù (come presentato da Terry Glaspey nella sua recensione degli insegnamenti di Lewis, Not a Tame Lion), “Un `valore` è un`idea che abbiamo in testa su come dovrebbero essere le cose, è un termine moralmente neutro che specifica una preferenza. La “virtù”, d’altra parte, è una qualità del carattere che porta all’azione. Troppo spesso i valori sono qualcosa su cui discutiamo solo; la virtù è un modo di vivere”.
Anche il Buddha ha qualcosa da dire sulla virtù come azione: “Proprio come i tesori vengono scoperti dalla terra, così la virtù appare dalle buone azioni e la saggezza appare da una mente pura e pacifica. Per camminare sicuri nel labirinto della vita umana, c’è bisogno della luce della saggezza e della guida della virtù”.
La virtù, come una sorta di ayni, è un trampolino di lancio verso il munay, perché il munay non è l`emozione dell`amore, ma la scelta dell`amore. È amore secondo la tua volontà. CS Lewis (sempre tramite Glaspey) dice che dovremmo diffidare delle nostre emozioni, perché sono fugaci e mutevoli. “[S]e aspettassimo di agire con virtù finché ne abbiamo voglia, potremmo aspettare per un tempo molto lungo. Non dobbiamo sentirci caritatevoli per agire con carità. Potrei non provare amore per un vicino difficile, ma potrei essere chiamato ad aiutarlo”.
Sia che chiami questo valore virtù sia che lo chiami ayni, è chiaro che è molto necessario nel mondo oggi. Invece di praticare valori comunemente condivisi, tendiamo a essere immersi in una sorta di relativismo morale in cui non c’è consenso sulle convenzioni in base alle quali misuriamo le nostre parole e azioni come utili, utili ed edificanti o meno. Al limite, sembra esserci una totale assenza di consapevolezza della necessità di norme morali. Nonostante la complessità di qualsiasi discussione sugli standard morali, penso che possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che quando manca la sensibilità morale, vacilliamo sul precipizio non solo del caos sociale, ma anche del tumulto interiore personale. Come scrive Yeats nella sua poesia “The Second Coming”: “Le cose vanno in pezzi; il centro non può reggere; / La semplice anarchia si scatena sul mondo, / La marea offuscata dal sangue si scatena, e ovunque / La cerimonia dell`innocenza è soffocata; / I migliori mancano di ogni convinzione, mentre i peggiori / Sono pieni di intensità appassionata.
Assomiglia molto al nostro mondo di oggi. . .
Questo “centro” è il nostro centro morale, la capacità di valori condivisi che ci elevano e alimentano sia la nostra evoluzione individuale sia quella della nostra umanità collettiva. L’individuo non può essere separato dal collettivo senza perdere una qualità essenziale di ciò che significa essere umani: ognuno di noi è il custode di nostro fratello e nostra sorella. Se l’ayni ci insegna qualcosa, sicuramente è questo.
Un chakaruna nella tradizione andina è colui che costruisce ponti: tra se stesso e gli altri, tra comunità, tra tradizioni, tra cielo e terra. Quando due gruppi si trovano separati da un fiume turbolento, ciascuno dei quali si riunisce su sponde opposte, il chakaruna – attraverso l`applicazione della volontà, dell`ayni o della virtù – inizia a costruire un ponte.
Con questo pensiero in mente, forse nel profondo non è la nostra delusione o disperazione per l’assalto mediatico di disinformazione e la nostra sfiducia (o disgusto) verso le persone che la creano e la perpetuano a disturbarci davvero. Forse, nel profondo, il nostro disagio è che stiamo assistendo, in modi senza precedenti, al distacco dell’individuo e delle “tribù” in guerra dalla consapevolezza delle nostre responsabilità personali e collettive per essere ciascuno membri produttivi e compassionevoli di una famiglia umana. La disintegrazione della coesione sociale può portarci su due strade: o porta a una dissoluzione potenzialmente disastrosa dei legami collettivi o alla nostra trasformazione collettiva. Il nostro disagio, in questo momento, potrebbe essere che la questione verso quale obiettivo stiamo correndo è del tutto aperta.
Quindi, nelle nostre brevi discussioni su questi argomenti in classe, i miei studenti e i miei compagni paqos e io tendiamo a concordare sul fatto che esiste un solo approccio certo. Non è un’intuizione sconvolgente. È l’antico adagio che abbiamo sentito da Buddha, Cristo, Gandhi e tanti altri: assumiti la responsabilità di te stesso.
Se ognuno di noi sceglie di essere portatore di sami piuttosto che di hucha, di essere chakaruna – se scegliamo di coltivare il nostro munay e migliorare il nostro ayni (e di agire secondo virtù in qualunque misura possibile) – allora ognuno di noi sta intraprendendo un vero e proprio cammino. atto rivoluzionario, e senza dubbio anche evolutivo. La sola intenzione non è sufficiente. Senza azione, non pratichiamo né ayni né virtù. Ritirarsi dalla sfera sociale o politica è certamente un’opzione, ma che, a mio avviso, significa un’abdicazione alla responsabilità sia personale che collettiva. Nessuno di noi può prosperare da solo. Ma non possiamo prosperare collettivamente se non accettiamo di onorare la nostra comune umanità, che inizia con il trattarci a vicenda con tolleranza, compassione, umiltà e gentilezza.
Come dico ai miei studenti: “Non è necessario che ti piacciano tutti o che tu sia amico di tutti, ma puoi essere in grado di portare una certa misura di sami in ogni interazione, non importa quanto impegnativa o difficile”. Alcuni di noi scelgono di non farlo. Ma alcuni di noi, a causa del nostro stato di coscienza e della quantità di hucha che portiamo con noi, non sono in grado di farlo. Se non siamo in grado di farlo, la scelta cessa di essere un fattore determinante e perdiamo parte del nostro potere personale. Se ne siamo capaci (malgrado le nostre umane emozioni), allora abbiamo acquisito una maggiore libertà personale.
(immagine di vecstock su Freepik)
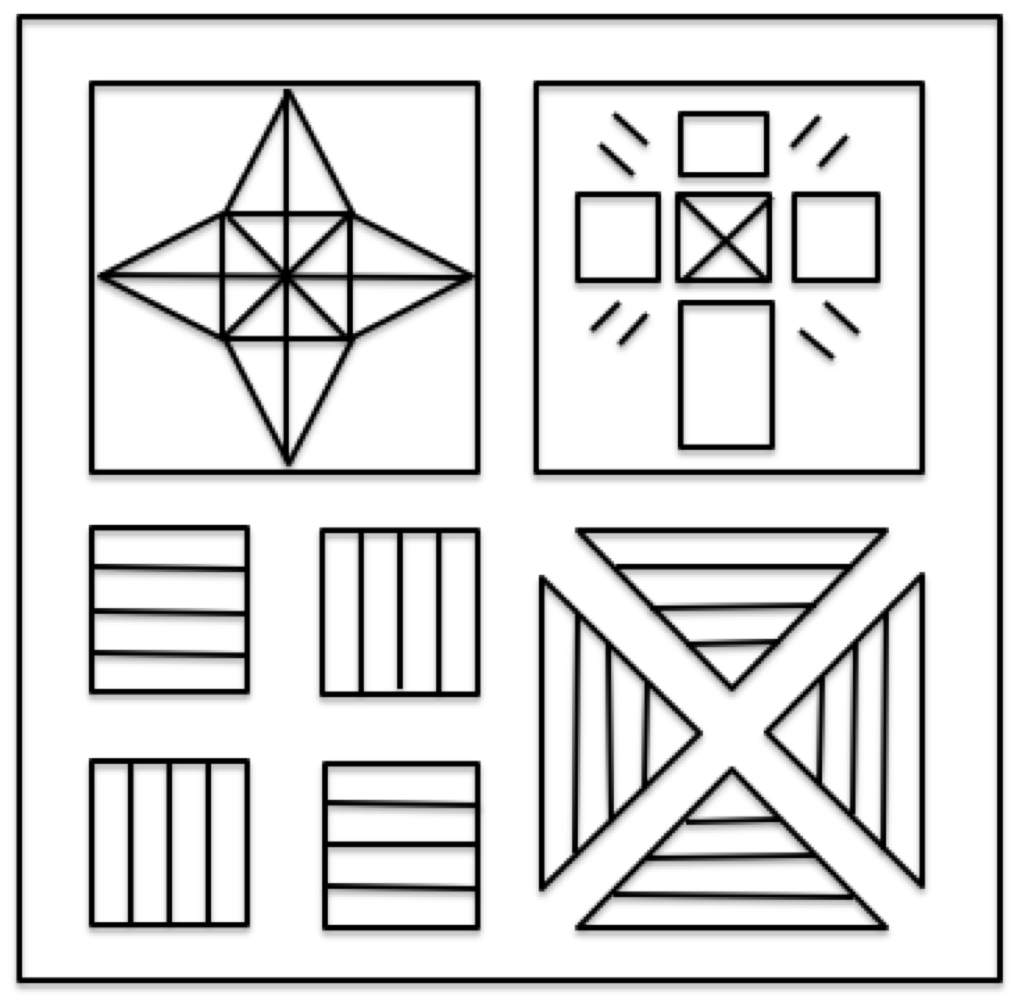

Comments are closed