di Joan Parisi Wilcox; traduzione Gianmichele Ferrero – Post corrente: 20 ottobre 2025
Era la fine degli anni Novanta e una festa era in pieno svolgimento: musica a tutto volume, drink a fiumi, conversazioni e risate che riempivano le sale. Ma io ero in un angolo tranquillo, immerso in una conversazione con Gloria Karpinski, un’insegnante di sviluppo umano di fama mondiale. Non ricordo come arrivammo all’argomento, ma stavamo discutendo di cosa significhi essere “spiritualmente maturi”. Alla fine, concordammo su una definizione concisa: la maturità spirituale è la capacità di “sedersi comodamente in grembo al paradosso”. Una volta risolta quella questione importante, tornammo alla festa e a tutta la sua allegria. Non ho mai dimenticato quella definizione, ed è il modo perfetto per introdurre la prossima “sensibilità mistica” sulla mia lista: coltivare il comfort con il paradosso.
Traendo spunto da diverse definizioni, il paradosso è un’affermazione che in superficie sembra contraddittoria o assurda, ma che, a una riflessione più approfondita, rivela una verità profonda. Spesso ci richiede di conciliare due idee opposte riconsiderando i nostri presupposti iniziali.
Alcuni paradossi non ci causano alcuna tensione interiore; semplicemente “li capiamo”. Abbiamo tutti sentito e usato questo tipo di affermazioni:
• Meno è meglio.
• L’unica costante è il cambiamento.
• Più sai, meno capisci.
• L’unica certezza è che nulla è certo.
Tuttavia, molti paradossi spirituali sono progettati per creare dissonanza interiore. Ci fanno fermare e ci chiedono di essere portati in contemplazione. Sfidano il nostro pensiero convenzionale e ci spingono a una comprensione più profonda.
• Sii nel mondo ma non del mondo.
• Devi perderti per trovare veramente te stesso.
• Se incontri il Buddha per strada, uccidilo.
• Il nulla è tutto, il tutto è nulla.
Una cosa è certa riguardo al paradosso: non è qualcosa da risolvere. Anzi, più ci sforziamo di risolvere l’apparente contraddizione, più ci allontaniamo dalla comprensione. La determinazione non è la nostra via d’accesso. Una classica storia buddista illustra questo punto. Uno studente chiede a un insegnante quanto tempo ci vorrà per padroneggiare i suoi insegnamenti. L’insegnante risponde: “Dieci anni”. “Ma”, promette lo studente, “sarò l’allievo più diligente e devoto che tu abbia mai avuto”. “In tal caso”, dice l’insegnante, “vent’anni”.
Mentre la logica spesso cerca risposte chiare e definitive, il paradosso spirituale offre una via diversa. È un potente strumento progettato per allentare il nostro rigido attaccamento alla logica e coltivare il rispetto per l’incertezza. Spostandoci oltre il pensiero o/o verso una prospettiva più integrale, sia/e, il paradosso sfida il bisogno dell’ego di categorizzazioni rigide e di significati semplicistici o superficiali. Incoraggia una consapevolezza più riflessiva, contemplativa ed espansiva. In definitiva, il paradosso ci aiuta a coltivare l’umiltà e la grazia necessarie per onorare i misteri della vita, promuovendo una maggiore tolleranza per l’astrazione e una fiducia più profonda nell’ispirazione.
Le parole – che nominano, definiscono, caratterizzano – sono totalmente inadeguate alle ricerche mistiche. Tra i più grandi doni del paradosso c’è quello di insegnarci che la “conoscenza” non è intellettuale, ma fenomenologica. Dobbiamo percecipre la “verità” e l’intuizione. In effetti, la percezione mistica è più una “nube di inconsapevolezza”, come ci dice il titolo di un classico testo mistico cristiano. Al di là di ogni pensiero, immagine e concetto intellettuale c’è lo spazio liminale in cui l’anima incontra e sperimenta il divino.
La maggior parte dei lettori di questo blog pratica le arti sacre andine. In questa tradizione incontriamo il paradosso, sebbene si presenti per lo più in modo sottile. Pratiche come saminchakuy e saiwachakuy, insieme alla riflessione e alla contemplazione, ci aiutano a percepire le verità spirituali più profonde che le parole e la logica non possono esprimere. Sono metodi che ci conducono verso l’interno, verso luoghi silenziosi e luminosi dove ascoltiamo anziché parlare, sentiamo anziché pensare e assorbiamo anziché imparare. Il paradosso di queste pratiche è che sono sia passive che attive, e né passive né attive. Incastonate nella quiete ci sono energie creative, ciò che nella tradizione andina chiamiamo ayni, o scambi reciproci. Come spiega il mistico cristiano Thomas Merton, “Una delle strane leggi della vita contemplativa è che in essa non ci si siede a risolvere i problemi: li si sopporta finché in qualche modo non si risolvono da soli. O finché la vita non li risolve per te”.
La collaborazione con la “vita” è al centro della tradizione andina e l’ayni è uno dei suoi principi fondamentali. Questo principio andino di reciprocità e mutualismo è un concetto fondamentale per gli Andini in molteplici ambiti della vita: personale, comunitario o sociale, e spirituale. A livello personale e sociale, viene comunemente spiegato come “oggi per te, domani per me”. Gli indigeni andini vivono una vita agricola, e questo tipo di ayni significa che quando hai bisogno di aiuto nei tuoi campi o con le tue mandrie, io sarò lì per te, e viceversa. Tuttavia, anche a questo livello personale, l’ayni non è mai uno scambio puramente transazionale. Implica sempre l’aumento del benessere di entrambe le parti. L’ayni insegna che il nostro benessere è intrinsecamente legato al benessere degli altri, incluso quello del mondo naturale. È una visione del mondo profondamente radicata, secondo cui tutto è interconnesso e che la reciprocità rafforza entrambe le parti.
A livello energetico, la paradossalità di ayni risiede nella sua duplice natura: è un’azione pratica e fisica nella vita, le cui radici affondano in una profonda spiritualità immateriale. Questo paradosso include la comprensione che ayni è prima di tutto uno stato di coscienza; tuttavia, senza azione non c’è ayni. Ayni implica volontà, scelta, consapevolezza e intenzione, ma la sua dinamica profonda è il fluire dell’essenza di ciascuno all’interno di campi energetici più ampi, da quello della sfera sociale umana a quello dell’allineamento con il cosmo. Praticare ayni rivela che siamo parte integrante dell’universo vivente, non separati da esso. In questo modo, ayni è un allineamento consapevole con la nostra vera natura.
Nella cosmovisione andina, lo spirituale e il materiale sono visti come due aspetti di un’unica realtà. Il termine quechua per questa polarità complementare è yanantin. Il concetto di yanantin nella filosofia andina presenta un paradosso potente e spesso frainteso. I dualismi occidentali (come bene contro male, giusto contro sbagliato, io contro te) tendono a enfatizzare una lotta per il predominio dell’uno sull’altro. Lo yanantin vede forze apparentemente opposte (come maschile/femminile, luce/oscurità, interno/esterno, io/tu) come parti essenziali e interdipendenti di un tutto unificato. Lo yanantin non riguarda il raggiungimento dell’equilibrio, ma dell’armonia. In una data situazione, un aspetto dello yanantin può essere più prominente, attivo o dominante, ma non vi è comunque alcuna asimmetria fondamentale. Le dinamiche energetiche mutevoli della coppia yanantin creano le condizioni per la crescita, il cambiamento, la varietà e la novità. L’essenza dello yanantin non risiede nell’attenzione alla sua dualità, o agli aspetti diversi ma complementari dei due elementi individuali, ma nella loro unità, nella totalità che nasce dalla loro essenziale relazione di complementarietà. In sostanza, lo yanantin è il paradosso di essere lo specchio di se stesso: di percepire simultaneamente la Molteplicità e l’Unità, e di comprendere che non si escludono a vicenda. (I paqo andini non si avventurerebbero nel panorama buddista della molteplicità come illusione, sebbene riconoscerebbero che la “separatezza” è un fraintendimento della natura fondamentale della realtà).
Qualunque sia il paradosso, come strumento spirituale è utile in molti modi. Sentirsi a proprio agio con il paradosso, ed essere quindi disposti ad abbracciarlo, può accrescere la creatività. Ci spinge a pensare, sentire e persino essere in modi che esulano dalla norma consensuale: ci addentriamo nella terra dell’intuizione creativa, dell’innovazione e della novità. Se trascorriamo del tempo lì, ci rendiamo conto che si tratta di un ambiente di delizia, rivelazione e persino gioia. Il paradosso ci invita a essere curiosi e creativamente adattabili: quando ci troviamo faccia a faccia con l’irrazionale e persino l’illogico, facciamo rapidamente amicizia con l’incertezza, la fluidità e le sfumature. Insieme, ci guidano verso modi innovativi di conoscere, comprendere, riflettere, agire, risolvere problemi, sentire, esprimere e scegliere. Mentre cerchiamo di armonizzare quella che sembra la tensione degli opposti, coltiviamo la capacità di riformulare e riconcettualizzare: non solo sulla natura del cosmo e del mondo – e sul nostro rapporto con essi – ma anche sulla nostra stessa natura umana. Dobbiamo affrontare le nostre incoerenze; e quando lo facciamo, accettiamo meglio gli altri e persino la vita in questo mondo così umano. Forse l’aspetto più significativo dell’accogliere il paradosso è che ci apriamo a una sorta di riverenza per la polarità in cui siamo immersi: la nostra essenza fisica e metafisica simultanea; la sorprendente complessità e la sorprendente varietà del mondo e di noi stessi, e la loro intrinseca eleganza; l’ostinata “essenza” della forma materiale mondana e il palinsesto del sacro che informa ogni cosa. Come afferma chiaramente il filosofo buddista Dōgen Zenji, questo paradosso: “Nel mondano, nulla è sacro. Nella sacralità, nulla è mondano”. Questa è la posizione del mistico, ed è per questo che quando facciamo amicizia con il paradosso, stringiamo un amico per la vita.
(immagine da Freepik)
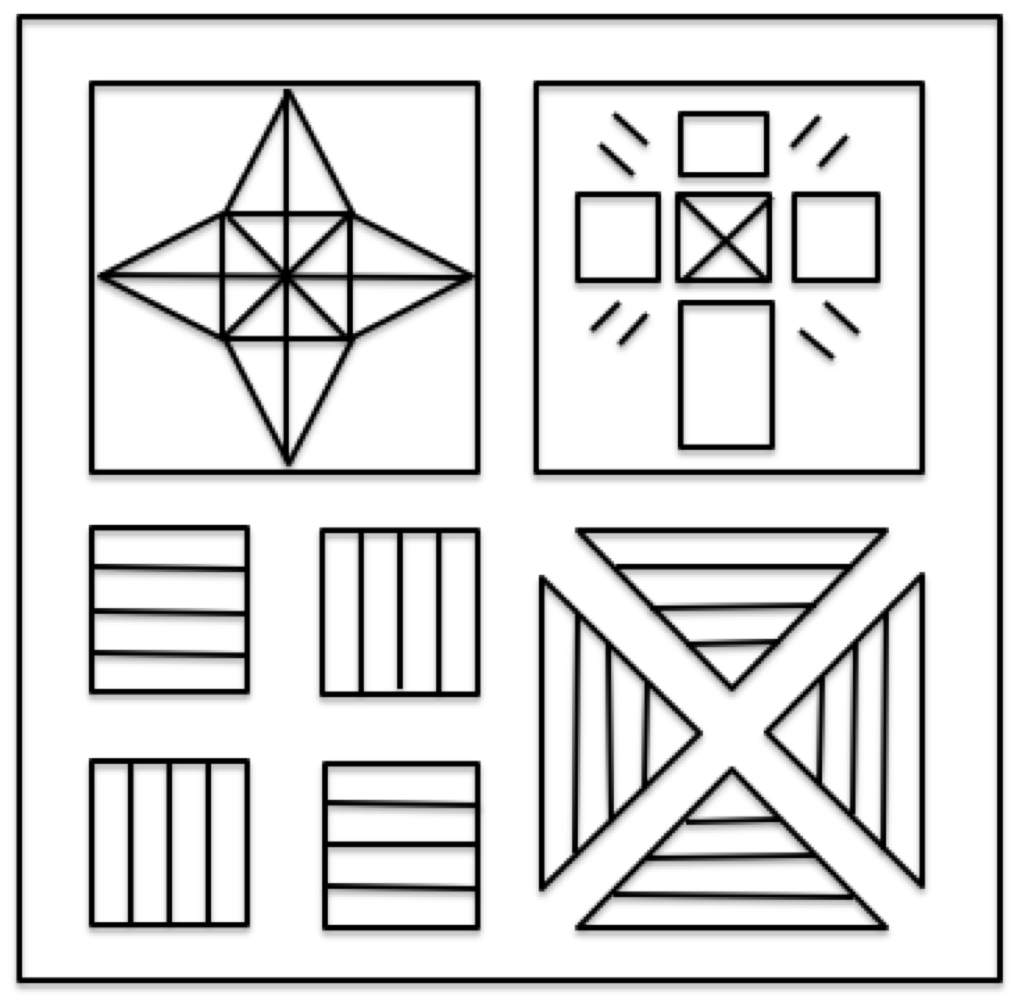

Comments are closed